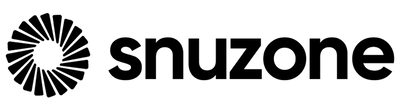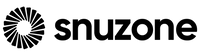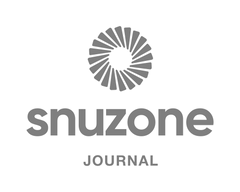Smettere di fumare – molti lo considerano un’impresa difficile. Tuttavia, di solito non sono solo i sintomi dell’astinenza da nicotina a rendere difficile la cessazione. Questi possono essere gestiti con farmaci o prodotti sostitutivi della nicotina. Piuttosto, le dinamiche psicosociali svolgono un ruolo essenziale. Possono esserci numerosi fattori sociali che favoriscono il consumo e rendono difficile smettere – ad esempio l’appartenenza al gruppo e la socialità legata al fumo nel proprio ambiente. Ciò è particolarmente vero quando anche fattori psicologici agiscono come potenti forze trainanti – in particolare i cosiddetti «schemi maladattivi», cioè modelli cognitivi e comportamentali disfunzionali, possono alimentare il consumo in modo sfavorevole quando sono presenti stimoli chiave.
>> Scopri di più su: Farmaci per smettere di fumare
Le ragioni di una cessazione difficile sono quindi complesse e non possono essere ridotte unicamente a possibili sintomi di astinenza. Il cosiddetto modello biopsicosociale suggerisce che occorre considerare almeno tre livelli in cui si trovano fattori favorevoli, che interagiscono reciprocamente, per l’inizio, il mantenimento e infine la difficoltà di smettere di fumare. Un abuso di nicotina può quindi essere compreso anche in modo olistico.
I metodi psicoterapeutici affrontano tali aspetti psicosociali – un esempio è la terapia cognitivo-comportamentale (TCC). E anche se non potrà mai sostituire una psicoterapia professionale, è possibile derivarne alcune tecniche di auto-aiuto.
Tecniche di auto-aiuto dalla psicoterapia come rimedi casalinghi per smettere di fumare
I rimedi casalinghi per smettere di fumare sono generalmente intesi come semplici metodi domestici e misure di automedicazione. Più in generale, tuttavia, un rimedio casalingo può anche essere una forma di soluzione o applicazione di aiuto auto-attuata a casa per smettere di fumare.
In questo senso, le tecniche di auto-aiuto della psicoterapia sono considerate rimedi casalinghi, con l’accento posto meno sull’«automedicazione» e più sull’«autointervento».
La terapia cognitivo-comportamentale è una scuola di psicoterapia che fornisce un supporto efficace nei casi di dipendenza da nicotina e nella cessazione del fumo, e può creare soluzioni durature. Nell’ambito del suo approccio, è possibile derivare tecniche che il paziente può applicare da solo per sostenere l’astinenza – e queste possono aiutare ad allentare, spezzare e infine modificare schemi di consumo e comportamenti rigidi e sfavorevoli insieme alle loro condizioni.
Analisi comportamentale situazionale: Modello SORKC
Per poter modificare/interrompere in modo duraturo il proprio comportamento di consumo, sembra essenziale comprendere quali stimoli chiave alimentano il consumo e perché lo fanno. Può anche essere utile ricordare quale valore psicosociale apporta il fumo – il consumo può infatti essere inteso in senso funzionale. Chi fuma sperimenta di solito conseguenze positive immediate dal proprio consumo – i cosiddetti rinforzi. In questo senso, il fumo è considerato un «fenomeno teleologico», un comportamento finalizzato allo scopo, rafforzato semplicemente dallo scopo da raggiungere (inteso in senso psicosociale).
Nella terapia cognitivo-comportamentale, l’analisi comportamentale iniziale è considerata un momento chiave per l’applicazione successiva di eventuali metodi terapeutici. Si distingue tra un’analisi comportamentale contestuale/verticale e una situazionale/orizzontale.*1
 |
Con un’analisi comportamentale si può innanzitutto avere una panoramica delle complesse interazioni tra cognizione, emozione e comportamento, chiarendo così le dinamiche psicosociali. - © Immagine: AdobeStock |
In particolare, l’analisi comportamentale orizzontale può chiarire in modo piuttosto semplice in che misura un comportamento di consumo è legato a stimoli situazionali, schemi maladattivi individuali e alle conseguenze associate al consumo. Da ciò si possono poi derivare metodi specifici che affrontano diversi aspetti e forniscono un supporto per smettere di fumare.
Il modello SORKC nello smettere di fumare
Un concetto riconosciuto dell’analisi comportamentale orizzontale è il cosiddetto modello SORKC.*2 Questo modello viene citato per mostrare in che misura le tecniche di auto-aiuto previste possono essere derivate, e soprattutto, perché e in che modo funzionano.
Lo schema SORKC è composto da cinque variabili:
| S ---> | O ---> | R ---> | K ---> | C |
- Stimolo (S): Comprende stimoli (chiave) legati alla situazione che precedono un comportamento (di consumo).
- Organismo (O): Comprende le basi biologiche e la storia di apprendimento di una persona – vi rientrano anche convinzioni di base, aspettative e bisogni fondamentali degli schemi maladattivi menzionati, che, quando attivati/evitati/sovracompensati da un trigger nella variabile stimolo, portano a reazioni rigide nella variabile reazione.
- Reazione (R): Qui vengono incluse tutte le reazioni osservabili (comportamento visibile) e non osservabili (cognitive, emotive e fisiologiche), che, a causa di fattori provenienti dalla variabile organismo, seguono stimoli situazionali. La classificazione negli stili di coping maladattivi (fuga, lotta, congelamento) può indicare se gli schemi maladattivi sono stati evitati, sovracompensati o attivati.
- Contingenza (K): Esprime la frequenza della co-occorrenza di situazione, comportamento e conseguenze.
- Conseguenza (C): Tutte le ricompense e punizioni risultanti dal comportamento.
Cosa sono gli schemi maladattivi?
Gli schemi maladattivi sono un concetto sviluppato da Jeffrey Young, che può essere descritto come segue:
Secondo Jeffrey Young, gli schemi maladattivi possono svilupparsi quando i bisogni emotivi fondamentali nell’infanzia e nell’adolescenza non vengono ripetutamente soddisfatti o vengono frustrati. Sono stati clinicamente ed empiricamente confermati 18 schemi differenti, assegnati a cinque domini (o temi) che riflettono a loro volta il bisogno fondamentale frustrato.
Lo schema viene quindi stabilito nello sviluppo individuale precoce come un modello duraturo e pervasivo di sentimenti, pensieri, ricordi e sensazioni corporee, nel senso di un «immagine interiore» delle condizioni reali della prima biografia. Questo modello può rafforzarsi nel corso dello sviluppo successivo e continua a guidare il comportamento quando viene attivato, anche se le condizioni esterne e le relazioni cambiano."*3
Secondo therapie.de, gli schemi maladattivi vengono inoltre descritti come:
"Uno schema comprende modelli duraturi e sfavorevoli di sentimenti, pensieri e ricordi che guidano il comportamento in una situazione concreta. Gli schemi possono riguardare la persona stessa (schemi del sé) o le sue relazioni con altre persone (schemi relazionali). Hanno un effetto negativo sulla vita della persona e vengono quindi anche chiamati «trappole di vita»."*4
Inoltre, va sottolineato che tali schemi determinano in larga misura la percezione del contenuto situazionale.
Attraverso convinzioni di base, aspettative (verso se stessi o verso gli altri) e bisogni fondamentali sfavorevoli, tali schemi maladattivi possono rappresentare fattori guida sull’Variabile Organismo. Le corrispondenti "reazioni maladattive", osservabili e non osservabili (fuga, lotta, congelamento), che sorgono da convinzioni di base, aspettative e bisogni sfavorevoli e direttivi degli schemi, si ritrovano infine nella Variabile Reazione. Gli stimoli chiave, attraverso i quali gli schemi maladattivi vengono attivati, evitati o sovracompensati, possono invece essere chiariti nella Variabile Stimolo in relazione alla situazione.
Con questo concetto, schemi comportamentali disfunzionali possono quindi essere messi in relazione con i loro stimoli chiave, le componenti cognitive ed emotive sfavorevoli attivate/evitate/sovracompensate attraverso di essi e le conseguenze successive. Ciò consente di riconoscere e comprendere cosa alimenta e guida il proprio comportamento di consumo nel caso del fumo e dove possono essere applicati approcci di modifica.
Ecco ora un elenco dei 18 schemi maladattivi – con le rispettive tipiche Convinzioni di base (CB), Aspettative (A) e Bisogni (B), come possono essere definiti nella Variabile Organismo*5:
- Abbandono/Instabilità
- Gli altri sono inaffidabili/instabili. (CB)
- Sarò abbandonato/lasciato solo. (A)
- Attaccamento e stabilità (B) - Sfiducia/Abuso
- Gli altri non sono sinceri, mi sfruttano/sono manipolativi/mi feriscono. (CB)
- Sarò ingannato/tradito/umiliato/sfruttato/manipolato. (A)
- Sicurezza e fiducia (B) - Privazione emotiva
- Gli altri non sanno offrire sostegno emotivo/non danno affetto, attenzione/comprensione/protezione. (CB)
- Sarò rifiutato/non compreso/non protetto. (A)
- Affetto, empatia e protezione (B) - Difettosità/Vergogna
- Sono inadeguato/cattivo/indesiderato/inferiore/incapace. (CB)
- Non sarò amato, rispettato, incluso; sarò svantaggiato, umiliato. (A)
- Amore, rispetto e autostima (B) - Isolamento sociale/Alienazione
- Sono fondamentalmente diverso dagli altri. (CB)
- Non apparterrò/sarò escluso. (A)
- Appartenenza, integrazione nella comunità (B) - Dipendenza/Incompetenza
- Non riesco a gestire nulla senza aiuto. (CB)
- Sarò sopraffatto; non ce la faccio senza sostegno. (A)
- Indipendenza, competenza (B) - Vulnerabilità al danno o alla malattia
- Sta per succedere qualcosa di grave. (CB)
- Sarò in pericolo, impotente. Perderò il controllo. (A)
- Sicurezza, valutazione realistica dei rischi (B) - Fusione / Sé non sviluppato
- Senza una vicinanza estrema con gli altri sono perso. (CB)
- Senza legame sarò disorientato. (A)
- Autonomia, identità, obiettivi propri (B) - Fallimento
- Sono incapace, stupido, inferiore nelle prestazioni. (CB)
- Il fallimento futuro è inevitabile. (A)
- Successi, fiducia in se stessi (B) - Pretesa/Grandiosità
- Sono superiore agli altri, ho diritti speciali. (CB)
- Gli altri devono sottomettersi ai miei bisogni. Successo, potere e fama. (A)
- Riconoscimento di limiti realistici, empatia (B) - Scarso autocontrollo/Disciplina insufficiente
- Posso cedere agli impulsi; evitare lo sforzo. (CB)
- Ci penseranno gli altri. (A)
- Autocontrollo, maggiore tolleranza alla frustrazione (B) - Sottomissione
- Devo sottomettermi/adattarmi agli altri per evitare conflitti. (CB)
- Se mostro i miei bisogni/emozioni, sarò rifiutato o punito. (A)
- Affermazione di sé, autonomia (B) - Autosacrificio
- I bisogni degli altri sono più importanti dei miei. (CB)
- Se mi prendo cura di me stesso, mi sento in colpa/sarò abbandonato. (A)
- Equilibrio tra cura degli altri e cura di sé (B) - Ricerca di approvazione e riconoscimento
- Solo attraverso risultati, adattamento o attrattiva valgo qualcosa. (CB)
- Se non piaccio, sarò rifiutato. (A)
- Autostima stabile, autenticità (B) - Negatività/Pessimismo
- La vita è piena di pericoli, delusioni e perdite. (CB)
- Accadrà qualcosa di brutto, il bene è ingannevole. (A)
- Ottimismo, speranza, equilibrio tra positivo e negativo (B) - Inibizione emotiva
- Mostrare i sentimenti è pericoloso o imbarazzante. (CB)
- Critiche, rifiuto, vergogna nell’espressione spontanea. (A)
- Libertà di esprimere le emozioni, spontaneità (B) - Standard elevati/Perfezionismo
- Devo sempre essere perfetto e rispettare standard elevati. (CB)
- Critiche o punizioni in caso di errori. (A)
- Accettazione, serenità, autostima incondizionata (B) - Punitività
- Gli errori devono essere severamente puniti – in me stesso e negli altri. (CB)
- Nessuna indulgenza; la punizione è necessaria. (A)
- Perdono, tolleranza, compassione (B)
Così come l’intensità individuale di uno schema specifico (da forme lievi a forme patologiche) può variare, anche la combinazione della presenza simultanea di più schemi può differire notevolmente tra le persone.*6
Cosa sono gli stili di coping maladattivi?
"Maladattivo" significa qualcosa come "poco adattato" o "inadeguato", il che implica una certa disfunzionalità per gli schemi maladattivi quando si tratta di affrontare e gestire, ad esempio, situazioni di stress. Sebbene venga implicato un comportamento di coping disfunzionale, questo è tuttavia distinto dallo schema stesso ed è inteso piuttosto come guidato dallo schema.
Facendo riferimento a Jeffrey Young, si distinguono tre tipici stili di coping maladattivo che – come detto – non appartengono allo schema stesso, ma seguono come reazioni ad esso e possono anche cambiare nel corso della vita:
- Evitamento (Flight): Lo stile evitante consiste nell’affrontare evitando o fuggendo l’attivazione completa dello schema maladattivo (EMS). Esempi tipici sono l’evitamento palese o la fuga da persone, luoghi, attività o situazioni che potrebbero attivare lo schema, così come azioni che intorpidiscono o distraggono dall’eccitazione emotiva spiacevole – come l’uso di droghe, altri comportamenti compulsivi, l’autolesionismo o il distacco emotivo.
- Sovracompensazione (Fight): Lo stile combattivo significa che una persona risponde alla minaccia dell’attivazione dello schema "contrattaccando" in un certo senso il messaggio centrale dell’EMS. Cioè: pensare, sentire e agire come se il contrario dello schema fosse vero. Autori più recenti hanno anche definito questo stile di coping come «inversione di schema». Esempio: qualcuno con uno schema di Difettosità/Vergogna potrebbe sovracompensare mostrando arroganza e comportandosi come se fosse superiore agli altri (cioè l’opposto del sentirsi inferiore).
- Sottomissione (Freeze): Lo stile di sottomissione implica la resa allo schema – il messaggio centrale dell’EMS viene accettato e ci si comporta come se fosse vero (le convinzioni di base, le aspettative e le emozioni/cognizioni associate vengono quindi attivate). Esempio: una persona con uno schema di Abbandono/Instabilità potrebbe arrendersi cercando o intraprendendo relazioni insicure o instabili (credendo che nessun partner potrà mai fornire in modo affidabile disponibilità emotiva e fisica). Tali persone possono credere di «non dover aspettarsi nulla di meglio». In alternativa, la sottomissione può avvenire anche in una relazione altrimenti sana – ad esempio cercando costantemente conferme o controllando il partner, perché "credono" allo schema che dice: «Prima o poi il mio partner mi lascerà» – anche se non ci sono prove oggettive a sostegno.*7
Per il comportamento di fumo, lo stile evitante sembra particolarmente rilevante, poiché il consumo può essere qui inteso come una «fuga» o «distrazione» da una completa attivazione dell’EMS e come un «attenuamento» dell’eccitazione emotiva spiacevole grazie all’effetto calmante della nicotina; anche se esistono casi concepibili in cui il comportamento di fumo potrebbe essere spiegato anche dagli altri due stili di coping maladattivi.
Esempio fittizio di un fumatore
Con un esempio fittizio di un calciatore che, in determinate situazioni di stress, ricorre inevitabilmente alla sigaretta, si vuole ora illustrare come lo schema SORCK possa essere utilizzato per comprendere un’analisi comportamentale orizzontale, come possano essere chiarite le dinamiche psicosociali che favoriscono il consumo di tabacco e come possano infine essere derivate possibili tecniche di auto-aiuto.
Importante: Sebbene ciò non possa in alcun modo essere paragonato a una terapia cognitivo-comportamentale professionale, può comunque servire superficialmente come orientamento, una sorta di guida.
H, il calciatore che non riesce a smettere di fumare:
 |
"H", un calciatore talentuoso, ricorre ripetutamente alla sigaretta – soprattutto dopo le sconfitte della sua squadra, il consumo diventa eccessivo. - © Immagine: AdobeStock |
- Stimolo (S): La squadra di H perde una partita importante e H manca un’occasione decisiva da gol.
- Organismo (O): H non ha mai davvero imparato a gestire sconfitte e perdite. A scuola è stato svantaggiato da un insegnante e, quando ha espresso il desiderio di studiare, gli è stato detto che non ci sarebbe mai riuscito. Oggi H si sente spesso incapace e pensa di non aver ancora raggiunto nulla nella vita. Nel calcio, invece, si sente particolarmente valorizzato dai successi e apprezza di essere rispettato dai compagni di squadra – questo gli dà fiducia e autostima. Tuttavia, prima delle partite è di solito molto nervoso, teme di comportarsi male, pensa spesso di essere inferiore agli avversari e si preoccupa di ciò che potrebbe accadere se la sua squadra perdesse "per colpa sua" (ad esempio segnando un autogol). Questo è effettivamente accaduto la stagione precedente, dopo di che l’allenatore lo ha severamente criticato davanti ai compagni. Fuori dal calcio, trascorre talvolta del tempo con i compagni, alcuni dei quali fumano e affermano che li rilassa.
- Reazione (R): Dopo la sconfitta, H si vergogna, si sente incapace durante l’analisi con l’allenatore e pensa che fallirà anche nella prossima partita. Si considera un cattivo giocatore e teme di essere indesiderato nella squadra perché ha mancato l’occasione. Prova anche palpitazioni e nervosismo. Successivamente rifiuta di andare a cena con i compagni e vuole solo lasciare il campo. A casa prende una sigaretta per distrarsi grazie all’effetto della nicotina, e più fuma, più sembra rilassarsi.
- Contingenza (K): Evitare il contatto con i compagni e fumare si è già dimostrata una strategia per H dopo diverse sconfitte.
- Conseguenza (C): Dopo tali sconfitte, evitare il contatto con i compagni aiuta H a sfuggire ad altri sentimenti e pensieri negativi. Inoltre, fumare gli permette di distrarsi e rilassarsi grazie all’effetto della nicotina. Questo attenua il suo disagio, le emozioni e i pensieri negativi. A lungo termine – e H lo sa – fumare potrebbe portare a un calo delle prestazioni calcistiche e a conseguenze sulla salute. Ma per il momento, questa strategia funziona ancora per lui.
Qui è possibile mettere in relazione, nello schema SORCK, specifici stimoli chiave, schemi maladattivi e uno stile di coping maladattivo con alcune conseguenze che rinforzano il comportamento di fumo:

© Immagine: Snuzone
Questo mostra cosa precede l’atto di fumare, come il fumo sia intrecciato in una rete di dinamiche psicosociali e come il comportamento di fumo venga alimentato come stile di coping maladattivo (con le conseguenti ricompense positive).
Da ciò si possono ora derivare una misura di auto-aiuto comportamentale e una cognitiva con un focus sullo smettere di fumare. Per mantenerlo concreto, l’esempio di H continuerà a servire come riferimento.
>> Potrebbe interessarti anche: Che sia nell’hockey su ghiaccio o nel calcio – perché lo snus è così popolare nello sport?
Un metodo comportamentale: soddisfare i bisogni invece di fumare
Fumare offre a H, nel senso di uno stile di coping maladattivo di fuga, la possibilità di attenuare l’eccitazione emotiva spiacevole. Questo perché la nicotina induce uno stato d’animo leggermente euforico e rilassante – per ulteriori dettagli, vedi: Effetti dello snus.
Quando H diventa consapevole del funzionamento intrecciato del suo comportamento di fumo nel quadro del modello SORKC, può fare il passo successivo concentrandosi sui bisogni dei suoi schemi maladattivi (nella variabile organismo) e cercando specificamente (osservabili) possibili comportamenti alternativi (per la variabile reazione) che, soddisfacendo questi bisogni in modo più sostenibile, portino a una riduzione delle componenti emotive e cognitive spiacevoli (nella variabile conseguenza).*7
I bisogni alla base degli schemi maladattivi di H sono:
- Esperienze di successo, fiducia in se stesso
- Amore, rispetto e autostima
La sfida consiste ora nel fatto che H deve pensare a possibili azioni (a lui già note) che possano soddisfare questi bisogni. Questo può sembrare piuttosto difficile e, nella pratica, il processo di attuazione di tali comportamenti al posto del fumo appare spesso complesso. Inoltre, probabilmente non tutti i bisogni fondamentali saranno soddisfatti allo stesso modo. Tuttavia, ciò può rappresentare un’opportunità per H di utilizzare consapevolmente il proprio repertorio comportamentale contro uno stile di coping maladattivo di fuga legato al fumo.
Nel caso di H, ci sono effettivamente tre attività concrete che già conosce e che possono facilmente essere utilizzate come future reazioni osservabili al posto del fumo – per contrastare le reazioni emotive e cognitive spiacevoli (non osservabili) innescate da una sconfitta calcistica nella variabile reazione. I seguenti hobby forniscono a H esperienze di successo, fiducia in se stesso e autostima in egual misura:

Il diagramma mostra quali hobby danno a H esperienze di successo, fiducia in se stesso e autostima. - © Immagine: Snuzone
Se la soddisfazione dei bisogni attraverso i vari hobby fosse di diversa intensità, ciò potrebbe essere illustrato con segmenti di cerchio di dimensioni diverse. In questo modo si potrebbe stimare l’efficacia potenziale nei vari casi. In alternativa, è possibile anche una valutazione tramite un punteggio su una scala da 1 a 10.
Perché e come funziona esattamente questo metodo comportamentale?
Con le conseguenze cognitive ed emotive positive attese, che possono essere ottenute attraverso la soddisfazione forzata dei bisogni con tali attività (hobby), si interviene già nella variabile reazione per compensare le reazioni emotive e cognitive maladattive (non osservabili) scatenate da una sconfitta calcistica. Ciò consente di sostituire specificamente il comportamento di fumo con alternative che privano il fumo del suo scopo di rilassamento e distrazione. Le componenti cognitive ed emotive positive della soddisfazione dei bisogni contrastano le componenti negative degli schemi maladattivi e le attenuano (nella variabile conseguenza) in termini di rilassamento e distrazione.
Si può quindi contrastare consapevolmente il fumo per «rubargli» il suo scopo – cioè la distrazione, il rilassamento, l’attenuazione dell’eccitazione emotiva e cognitiva spiacevole. Le componenti cognitive ed emotive positive evocate intenzionalmente dalla soddisfazione dei bisogni non solo svolgono lo stesso scopo del fumo, ma reindirizzano persino le reazioni (non osservabili) derivanti dagli schemi maladattivi verso il positivo; le componenti negative scompaiono quindi. In questo modo lo stile di fuga maladattivo può essere neutralizzato e il comportamento di fumo finalizzato a uno scopo può essere prevenuto/fermato in futuro. Come risultato, nella variabile conseguenza compare una ricompensa analoga a quella del fumo, ma in più scompare la punizione legata al fumo (ad esempio un calo delle prestazioni a lungo termine, ecc.).
Nota: H non cade quindi in uno stile di coping di lotta, ma piuttosto, soddisfacendo i bisogni fondamentali dei suoi schemi maladattivi, può stroncare sul nascere la reazione di coping sfavorevole « fumare » e allo stesso tempo indebolire le convinzioni e le aspettative fondamentali degli EMS. In ogni caso, H ottiene così un rallentamento dello stile di fuga che alimenta il fumo e, di conseguenza, un’alternativa sana ad esso. Inoltre, attraverso tali comportamenti alternativi che soddisfano i suoi bisogni fondamentali, H può in futuro ridurre una certa pressione al consumo motivata psicologicamente, a cui si era condizionato con la regolarità della « risposta fumo » alla « situazione di sconfitta » visibile nella variabile contingenza.
Un metodo cognitivo: la tecnica delle 7 colonne
Un’altra tecnica di auto-aiuto è la cosiddetta tecnica delle 7 colonne. Si tratta di un metodo cognitivo, in quanto si concentra specificamente sulle componenti cognitive degli stili di coping maladattivi. In pratica, nell’ambito di un protocollo di pensieri, si individuano i cosiddetti « pensieri automatici », che compaiono come risultato di una (parziale) attivazione degli schemi maladattivi nella variabile reazione. Successivamente, in forma di colonne, si raccolgono « prove » a sostegno, « controprove » e « pensieri alternativi ed equilibrati » – con l’obiettivo di attenuare le conseguenze emotive di tali « pensieri automatici ».*8
Nel caso di H, tali pensieri automatici sono: « Aver fallito, fallire di nuovo in futuro ed essere indesiderato nella squadra. » Applicata a questo, la tecnica delle 7 colonne si presenta così:

© Immagine: Snuzone
Perché e come funziona esattamente questo metodo?
Come si vede nella colonna 7, questo metodo mira a rilassarsi e a rallentare le reazioni maladattive. Ciò che il fumo ottiene – ossia attenuare la vergogna, il senso di incapacità e la nervosità – può essere raggiunto anche con la tecnica delle 7 colonne. L’efficacia di questo metodo cognitivo può quindi essere descritta in modo simile a quella del metodo comportamentale menzionato, in quanto il fumo viene privato del suo scopo. La reazione maladattiva di fuga del fumo viene così neutralizzata, perché non è più necessaria. Infatti, se il rilassamento e la distrazione/l’attenuazione dell’eccitazione cognitiva ed emotiva vengono ottenuti in altro modo, la necessità di fumare scompare – non c’è più bisogno di « fumare via ciò che può svanire diversamente ».
A differenza del metodo comportamentale, questo metodo cognitivo può essere interiorizzato in modo tale da agire più rapidamente nella variabile reazione attraverso processi puramente cognitivi. In realtà, si potrebbe dire meglio: [...] attraverso un processo metacognitivo complessivo, poiché si tratta qui di un processo di riflessione che sovrappone uno schema di pensiero appreso ai pensieri emersi, e che diventa efficace nel senso di monitoraggio metacognitivo e autoregolazione.
Combinazione di tecniche di auto-aiuto comportamentali e cognitive come chiave del successo
Entrambe le tecniche di auto-aiuto menzionate – se applicate in combinazione – offrono ora a H gli strumenti necessari per dire finalmente addio alla sfavorevole « risposta al fumo » nelle note situazioni di stress di una sconfitta calcistica.
Nota bene: Le due tecniche di auto-aiuto derivate possono aiutare come rimedi casalinghi per smettere di fumare nel modo descritto, ma non sostituiscono in alcun modo una psicoterapia professionale. L’obiettivo di questo articolo era piuttosto quello di sensibilizzare al fatto che smettere di fumare non è così difficile solo a causa dei possibili sintomi di astinenza, ma che anche le dinamiche psicosociali possono svolgere un ruolo essenziale. L’analisi comportamentale situazionale descritta può quindi essere intesa solo come un aiuto all’orientamento, volto a incoraggiare l’autoriflessione. Le tecniche di auto-aiuto che ne derivano possono quindi essere intese solo come consigli.
>> Potrebbe interessarti anche: Disassuefazione dal fumo resa più facile
-----------------------------------------------
Fonti (ultimo accesso il 08.09.25):
*1 https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/verhaltensanalyse
*2 https://flexikon.doccheck.com/de/SORKC-Modell
*3 https://schematherapie-rhein-ruhr.de/schemata-nach-j-young/
*4 https://www.therapie.de/psyche/info/therapie/schematherapie/schemata/
*5 Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). Terapia degli schemi: un manuale pratico. Beltz Verlag.
*6 https://www.beltz.de/fileadmin/beltz/leseproben/978-3-621-28224-6.pdf
*7 https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-guide-to-schema-therapy/from-core-emotional-needs-to-schemas-coping-styles-and-schema-modes/721F16740657C4AD7C054AD8A7E3D9B1 ; in particolare: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/721F16740657C4AD7C054AD8A7E3D9B1/9781108927475c1_1-15.pdf/from-core-emotional-needs-to-schemas-coping-styles-and-schema-modes.pdf
*8 https://ulb-dok.uibk.ac.at/download/pdf/7714137.pdf